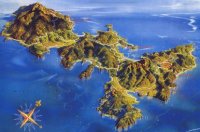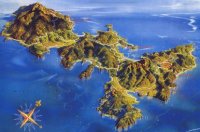Gli scritti di Antonio Pezzullo
|
|
CARAVAGGIO 2025
MOSTRA DEL GIUBILEO
Un’esperienza di Bellezza e Verità, Umanità e Modernità

|
|
Locandina della mostra
|
“A Roma c’è un tale Michelangelo da Caravaggio che fa cose meravigliose…la sua è una maniera straordinariamente adatta ad essere seguita dai giovani”
Le parole del suo primo biografo, Karel Van Mander, sono le più adatte, ancora oggi, a descrivere la mostra-evento Caravaggio 2025 che si può definire una straordinaria esperienza di bellezza, verità, umanità e modernità.
Questi valori fondamentali dell’arte di Caravaggio, che è stato definito come “il primo pittore dell’età moderna”, furono avvertiti subito solo da una parte dei suoi contemporanei. Dopo la sua morte, seguirono secoli di oscurantismo, in cui le sue opere vennero quasi dimenticate per il suo “stile” che i critici e i detrattori definivano “di poca maniera”, fino ad essere finalmente riscoperto nella seconda metà del Novecento. Da allora, l’apprezzamento della sua arte è stata una marcia inarrestabile, con un crescendo di consensi di critica e di pubblico che ancora oggi non accenna a fermarsi.
La bellezza e verità, l’umanità e l’attualità della sua opera è stata (ancora una volta) confermata dall’entusiasmo del pubblico che è accorso in massa ad ammirare questo maestro così geniale nella sua arte quanto sregolato nella sua vita. E l’omaggio non poteva avvenire se non nella magnificenza di Palazzo Barberini a Roma, nella stessa casa che fu di uno dei suoi più famosi committenti, il cardinale Maffeo Barberini, divenuto poi papa col nome di Urbano VIII.

|
|
Palazzo Barberini - Roma
|
Del resto, se c’è un pittore del passato in cui la nostra epoca si è identificato, questo è sicuramente Caravaggio. Come il genio di Michelangelo Buonarroti liberava le forme ed i corpi che solo lui vedeva intrappolati nel marmo, così quello di Caravaggio strappava dal nulla e dal buio della tela stupende forme, naturali o umane, e l’anima dei corpi, attraverso lame di luce taglienti e sfolgoranti.
Curiosamente, la mostra "Caravaggio 2025", nata proprio in occasione dell’anno santo giubilare proclamato dalla Chiesa cattolica, è diventata a sua volta un luogo di pellegrinaggio artistico, un evento che è andato ben oltre la mostra per trasformarsi in un vero e proprio rito collettivo.
In effetti, appena varcato le soglie del prestigioso palazzo, oggi Museo nazionale di arte antica, ho subito avuto l’impressione che questa mostra non fosse solo una sublime esposizione, ma sarebbe stata anche un'evocazione, un’ostensione del "Caravaggio in purezza": un concentrato di capolavori mai riuniti prima d'ora. Un vero e proprio “miracolo artistico” che i sapienti curatori hanno reso possibile grazie ai numerosi prestiti arrivati da tutto il mondo, con buona pace di chi pensa (forse gli invidiosi) che sia “solo” un’operazione commerciale ben riuscita.
Inoltre, la scelta di escludere le tele custodite nelle chiese romane (ed italiane) è stata molto saggia, non ha tolto niente alla grandiosità della mostra. Anzi, si può dire che rappresenta uno speciale invito rivolto implicitamente a quello stesso pubblico che è venuto ad ammirarlo: per comprendere veramente l’arte di Caravaggio, è necessario fare – appena possibile - un altro pellegrinaggio, più lungo, partendo dalle vie di Roma, per poi proseguire nei vicoli di Napoli, passando per Messina e Siracusa fino a Malta, alla ricerca delle sue opere nate nel loro contesto originario.
Il percorso di questa meravigliosa mostra è suddiviso in 4 sale disposte in ordine cronologico e presenta una selezione di ben 24 opere che vanno dal debutto romano fino agli ultimissimi mesi della sua vita. Le foto sono le mie personali, tranne quelle dove è diversamente indicato.
SALA 1: IL DEBUTTO ROMANO
I primi due quadri che s’incontrano sono effettivamente le prime opere note del maestro, quando il giovane Merisi irruppe sulla scena romana dopo l’apprendistato fatto a Milano.
Bacchino malato (1593/94) - olio su tela - 67x53 cm
Galleria Borghese (Roma)
Gli studiosi del Caravaggio ritengono che questo sia stato uno dei primi quadri dipinti dal maestro, probabilmente il più antico che si conservi, nato durante la sua permanenza nella bottega dal suo maestro romano, il Cavalier d’Arpino.
La sua carriera inizia col dipingere nature morte e le prime mezze figure. Il quadro rispecchia questa tendenza pittorica, ancora ispirata alla tipica tradizione lombarda. “Bacchino malato” sarebbe una raffigurazione di Bacco, che è un suo probabile autoritratto, caratterizzato da un forte naturalismo dovuto anche alla precaria condizione di convalescenza del pittore in seguito al ricovero per un calcio di cavallo subìto. Nonostante ciò, la luce lo scolpisce, impietosa e redentrice.
Da notare la semplice ma splendida raffigurazione di elementi di natura morta (uva, mele, pesche) presenti nel dipinto. Il quadro rimase, con altri, nello studio del Cavalier d’Arpino e fu requisito successivamente in questa bottega da Papa Paolo V per motivi fiscali. In realtà fu probabilmente un pretesto per consegnare le opere al nipote Scipione Borghese, avido collezionista dei dipinti del Caravaggio.
Ragazzo che monda un frutto (1595-96) - olio su tela - 63x53 cm
Collezione reale, Hampton Court Palace, Londra
ll “Ragazzo che monda un frutto” (detto anche Mondafrutto) è una delle prime opere romane del Merisi ma si presume che l’originale sia andato perduto. Tuttavia, essendo un quadro che ebbe un discreto successo, fu molto riprodotto ed oggi ci sono diverse copie in circolazione che complicano le difficoltà a comprendere quella più vicina all’originale.
Fu dipinto nel periodo in cui il Merisi lavorava nella bottega romana del Cavalier d’Arpino. Rappresenta un ragazzo ben vestito, pulito, che sbuccia un frutto misterioso, che gli studiosi moderni hanno ipotizzato in un limoncello napoletano, il cui succo era tradizionalmente usato come un naturale disinfettante intestinale. Il dipinto potrebbe dunque evocare valori di pulizia ed igiene, una specie di sussurrato monito morale. Il modello rassomiglia molto al ragazzo che Caravaggio utilizzerà anche per un altro dipinto, il “San Francesco in estasi”.
Questa esposta alla mostra è una delle migliori copie in circolazione e fa parte della collezione d’arte privata dei reali inglesi. Un’altra copia di valore è quella che si trova a Firenze, nella Fondazione Roberto Longhi, il massimo studioso di Caravaggio del secolo scorso, a cui si deve il merito della moderna riscoperta dell’opera del maestro.
I Bari (1594) - Olio su tela – 94x131 cm
Kimber Art Museum - Fort Worh, Texas (USA)
A Roma, fin da giovane l’artista rivoluzionò completamente i canoni della pittura tradizionale: fu infatti il primo a rappresentare la realtà così come si presentava, senza idealizzazione, nella sua più cruda e spesso sconvolgente verità.
“I Bari” è uno splendido dipinto che nasce nel 1594 quando Caravaggio è ospite a Palazzo Madama, nella residenza del cardinale Francesco Del Monte, ambasciatore mediceo presso la Santa sede nonché suo primo committente e mecenate. In quel periodo, l’alto prelato commissionò all’artista anche altri due quadri, la “Buona Ventura” ed il “Concerto”.
Anche se “I Bari”, come la “Buona Ventura”, sono ispirati alla commedia dell’arte, alle cosiddette “zingaresche” dove ricorre il tema della gioventù ingenua raggirata dalla malizia, tuttavia il pittore, in questi due quadri, ritrae una delle tante scene che quotidianamente si manifestavano per le vie di Roma, in una dimensione reale e naturale. Nella piena espressione della sua umanità, l’opera è volutamente raffigurata tutta in primo piano, in modo da garantire un maggior coinvolgimento emotivo dello spettatore, che di fatto si sente un partecipante attivo dell’immagine rappresentata.
Un giovane dal viso pulito, ben vestito in abito scuro come un nobile del suo tempo, sta giocando a carte con un altro giocatore dall’abbigliamento sgargiante ed un po’ trasandato. Quest’ultimo ha un complice della stessa risma che si posiziona alle spalle del giovane e suggerisce le carte al compare che, nel frattempo, sta tirando fuori da dietro la schiena, di nascosto, la carta necessaria che lo farà vincere.
“I Bari” sono un teatro crudele della vanità umana, dove la potente luce di Caravaggio blocca i volti, le mani rapaci, l'ingenuità che viene divorata dalla frode.

L’artista, illustrandoci contemporaneamente la bellezza e la realtà, vuole darci un monito morale contro il malcostume del gioco d’azzardo (o della preveggenza come nella Buona Ventura). La modernità del messaggio è evidente: il nostro mondo, oggi come allora, non è poi tanto cambiato.
Nei Bari si può iniziare ad ammirare la sua strepitosa resa pittorica, attentissima ai minimi dettagli, e l’uso della luce naturale che colpisce violentemente le figure modellandole nel chiaroscuro, consacrando il nome del maestro alla fama immortale.
Il dipinto fa parte di un trittico (insieme a Concerto e Buona Ventura) che erano appartenuti al cardinal Del Monte. Dopo tanti secoli, finalmente i tre quadri ritornano a stare insieme come lo erano nello studio del cardinale. Sono indubbiamente tra i miei capolavori preferiti del grande maestro.
La Buona Ventura (1593-95) - olio su tela - 115x150 cm
Musei Capitolini, Roma
Di questo celebre quadro, così come di altri del maestro, esistono due versioni. La versione in mostra è quella che si trova nella Pinacoteca Capitolina di Roma.
Il dipinto è un esempio delle novità dirompenti introdotte nella pittura da Caravaggio, ossia la rappresentazione di una scena di vita di strada nella Roma del suo tempo, utilizzando dei modelli trovati per le vie, come una giovane e seducente zingarella che ha preso dolcemente la mano ad un ingenuo giovane per predirgli il futuro. Partendo dal fondo della tela, l’autore costruisce uno spazio indefinito ma reso reale dalla luce naturale che invade il campo pittorico e costruisce forme e volumi. Tuttavia, il soggetto dell’opera non è solo quello che si vede. La giovane, nel prendergli la mano e senza farsene accorgere, con un gesto rapido gli sfila l’anello che l’imprudente giovane ha al suo anulare destro. È un chiaro monito a non farsi ingannare dalle apparenze e, più in generale, a non cedere alle seduzioni dei falsi profeti.

Caravaggio stesso affermava che la natura l’aveva fornito di maestri a sufficienza e non aveva perciò bisogno di prendere come riferimento delle sue opere dei “modelli classici”.
Come in un altro famoso dipinto di questo primo periodo (I Bari), Caravaggio, illustrandoci contemporaneamente la bellezza e la realtà, vuole dare un monito morale contro il malcostume della preveggenza o, come nei bari, del gioco d’azzardo.
Straordinari sono, come sempre, i dettagli pittorici come ad esempio qui la riproduzione del manico della spada del giovane, che è un autentico pezzo di bravura del maestro. Sembra davvero una fotografia!
I Musici (Concerto) (1595) – Olio su tela – 88x116 cm
Metropolitan museum of art, New York (USA)
Il dipinto, appartenente al suo primo periodo romano, fu commissionato dal cardinale Del Monte, suo mecenate e uomo di grande cultura che aveva un vivo interesse per l’arte e la musica. È uno dei dipinti giovanili più complessi di Caravaggio, per la presenza di ben quattro figure che probabilmente furono dipinte dal vivo. Il ragazzo che suona il liuto è il ritratto di un suo amico pittore (Mario Minniti) mentre quello accanto è un suo autoritratto giovanile.
È una fantasia allegorica sul tema della musica, con i giovani che sono idealizzati in un contesto astratto ma con volti raffinati e delicati. Nonostante il fatto che fosse un’allegoria sulla musica, nel dipinto l’artista conserva comunque il suo stile di dipingere i suoi modelli direttamente sulle sue tele senza disegni preparatori e soprattutto creando opere d'arte che raffigurano le persone nel modo più naturale possibile, anche se qui sono vestiti con abiti d’epoca classica.
Il quadro ha una lunga storia di passaggi di proprietà. Certificato sin dagli inizi nell’inventario dei beni del cardinale Francesco Del Monte come «una Musica di mano di Michelangelo da Caravaggio con cornice negra di palmi cinque in circa», fu poi acquistato dal cardinale Antonio Barberini che a metà del Seicento lo donò all’ambasciatore francese presso la Santa sede. Arrivò così in Francia e fece parte della collezione del celebre cardinale Richelieu. Successivi passaggi ottocenteschi lo fecero approdare a Londra in un’asta di Christie’s. Dopo altri giri privati di cui si persero le tracce, venne riscoperto solo nel 1951.
Nel 1952, tramite un’asta di Christie’s, il dipinto fu acquistato dal Metropolitan Museum of Art di New York, dove oggi si trova.
San Francesco in Estasi (1594-95) - Olio su tela – 92,5x128,4cm
Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut (USA).
L'opera è riconducibile al quadro di San Francesco registrato a Roma nel 1639 nell’inventario post mortem dei beni del banchiere Ottavio Costa, uno dei primi estimatori dell’artista. Probabilmente, fu il primo dei lavori che il banchiere gli commissionò: successivamente gli avrebbe commissionato anche altri due celebri quadri come “Giuditta decapita Oloferne” e il “San Giovanni battista nel deserto”.
Il San Francesco in Estasi è un dipinto notturno di grande originalità e delicatezza. A sinistra, sullo sfondo immersi nel buio s’intravedono frate Leone, assopito, e un gruppo di pastori. Qui abbiamo un modo molto originale di rappresentare l’episodio della vita del santo legato alla ricevuta delle stimmate. L’artista non fissa quel momento, non rende visibili le stimmate ma ci porta al momento immediatamente successivo dell'abbandono mistico. San Francesco sta vivendo una forte esperienza interiore e lo sorregge un angelo consolatore. La figura dell'angelo è di una bellezza struggente (il modello utilizzato potrebbe essere il suo amico e pittore Cecco di Caravaggio), mentre la luce divina, proveniente da una fonte invisibile, investe entrambi come un tocco soprannaturale.
Oggi esistono varie copie dello stesso quadro. La critica moderna ritiene che l’originale sia questa versione di Hartford, di grande qualità pittorica. Questo dipinto oggi è fuori dall’Italia, dove era sempre rimasto, perché nel 1938, ritenendolo una copia, fu concessa la sua esportazione e vendita. Dopo alcuni passaggi sui mercati dell’antiquariato, fu acquistato nel 1943 dal museo di Hartford. È stata così la prima opera di Caravaggio ad approdare in una collezione pubblica americana.
Una delle copie più note (molto vicina all’originale) è ritenuta la versione conservata attualmente nel Museo Civico di Udine.
Conversione di Saulo (1600-01) - Olio su tavola di cipresso - 237x189 cm
Collezione privata Odelscalchi, Roma
In questa grande sala si trova anche la prima versione della “Conversione di Saulo” che doveva andare nella Cappella Cerasi della chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma. La scena ritrae il momento culminante in cui, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo con una luce accecante e gli ordina di desistere dal perseguitarlo e di diventare suo «ministro e testimone».
Il grande quadro è caratterizzato dalla ricchezza cromatica di colori caldi, densi e profondi nonché dalla presenza di varie figure, tra cui quella di Cristo che irrompe fisicamente nella scena, un corpo divino troppo vero, troppo terreno per la convenzione del tempo. Non si tratta di un’apparizione celeste distaccata ma di un evento che ha luogo nel mondo terreno. Gesù è assistito e sorretto da un angelo, mentre Saulo, caduto dal cavallo, con le mani si copre gli occhi accecati dalla luce divina. Saulo è affiancato da un vecchio soldato che lo accompagna. Dietro le figure, c’è uno dei pochi sfondi dipinti dall’artista nelle sue opere, fatto da un paesaggio campestre da cui si scorge un fiume, che è l'Aniene.
È una versione abbastanza diversa dalla versione definitiva della “Conversione di San Paolo”, dove per quest’ultima al centro della scena emerge la figura del cavallo. Qui invece il cavallo è sempre un elemento necessario ma di riempimento. Tuttavia, in entrambi le versioni, la luce del suo pennello non descrive semplicemente l’evento ma lo rivela.
La storia di questo dipinto è particolare. A Caravaggio venero commissionati due dipinti su “tavole di cipresso” da inserire nei laterali della Cappella Cerasi, avente come tema rispettivamente la Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo. L’artista dipinse queste due tavole prima ancora che fossero completati i lavori di sistemazione della Cappella. Probabilmente, ci si accorse a posteriori che le tavole non s’inserivano bene nella nuova sistemazione e fu probabilmente proprio questa la ragione (e non un rifiuto del committente) per cui Caravaggio dovette rifare i due dipinti (questa volta su tela), che oggi sono quelli che si vedono in loco. Le tavole furono invece conservate dall’artista nel suo studio per poi essere vendute successivamente. Attraverso i secoli, la prima versione della Conversione di Saulo è ritornata in Italia mentre la prima versione della Crocifissione di San Pietro si ritiene perduta, dato che non si hanno più tracce.
La Conversione di Saulo (chiamata anche Conversione Odescalchi) è tra le pochissime opere di Caravaggio ancora oggi in mano privata ed è sicuramente un dipinto di grande qualità e d’attribuzione certa. È molto raro, se non impossibile ai comuni mortali, vederlo pubblicamente e per questo costituisce una delle “chicche” più preziose della mostra.
Narciso (1597-99) - Olio su tela - 112x92 cm
Palazzo Barberini, Roma
Narciso è un personaggio della mitologia greca, un giovane cacciatore famoso per la sua bellezza che, insensibile all’amore, non ricambiò la passione di una ninfa. A seguito di una punizione divina, s'innamorò della sua stessa immagine riflessa in uno specchio d'acqua e morì cadendo nel lago in cui si specchiava.
Il mito di Narciso è qui celebrato ritraendolo proprio nel momento esatto in cui si china a bere in uno specchio d’acqua e viene rapito dal suo riflesso. Il pittore trasporta il mito nel suo presente, vestendo il ragazzo con abiti seicenteschi. Il risultato è un efficace gioco tra realtà ed illusione.
L’attribuzione del dipinto al Caravaggio divide la critica. Il primo ad attribuirlo al Merisi fu il grande critico d’arte Roberto Longhi nel lontano 1913 e da allora si sono accodati altri esperti. In tempi più recenti sono stati sollevati diversi dubbi ed alcuni critici d’arte l’hanno attribuito ad un pittore caravaggesco, lo Spadarino. Al di là della certezza dell’attribuzione, si tratta comunque di un’invenzione pittorica che non potrebbe sussistere senza l’arte rivoluzionaria di Caravaggio. L’unica documentazione storica ritrovata, nell’archivio di Stato di Roma, è una licenza di esportazione del 1645 intestata ad un certo Valtabelze in cui, fra altre opere in partenza per Savona, è indicato un dipinto del Caravaggio raffigurante Narciso. È probabile dunque che il dipinto possa essere stato dipinto per il cardinale Del Monte durante il soggiorno del pittore a Palazzo Madama, abitato dal suo mecenate.
SALA 2: INGAGLIARDIRE GLI OSCURI
Se alcune opere della mostra sono così famose che, quando le rivedi, hai l’impressione di aver ritrovato un vecchio "amico", ci sono altre opere che invece suscitano un grande interesse, poiché sono tele molto meno note. Questa sala si apre con due ritratti, messi l’uno accanto all’altro, di Maffeo Barberini, l’antico padrone di casa di questo omonimo palazzo, diventato poi papa col nome di Urbano VIII. Di Caravaggio ritrattista non si hanno molte notizie ma era pur sempre un grande artista, capace di fissare sulla tela l'anima del personaggio oltre che il suo corpo.
Il doppio Maffeo Barberini ne è la prova: dalla figura più convenzionale del primo, forse opera della sua cerchia anche se intervenuto in parte direttamente, all'esplosione psicologica del secondo ritratto. In quest’ultimo qualche critico ha affermato che c’è la nascita dell'uomo moderno sulla tela: l'ambizione, l'intelligenza, il gesto sospeso catturato dalla luce che lo sbalza dal buio, rendendolo presenza viva, quasi un interlocutore. Con questa prospettiva laterale, qui sopra riportata, si ha persino la sensazione che la mano destra sembra debordare dal quadro!
Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini (1595) - Olio su tela - 122x95 cm
Collezione privata, Firenze
Il ritratto fu registrato nell’inventario di Maffeo Barberini sin dal 1608. Attraverso vari passaggi ereditari rimase sempre nelle collezioni private dei Barberini fino a pervenire, tramite eredità, ai Corsini di Firenze.
Questo ritratto dovrebbe raffigurare il monsignore Maffeo nelle vesti di Protonotariato Apostolico. È un ritratto sulla cui attribuzione al Caravaggio non c’è unanimità. Del resto, fino all’Ottocento, questo ritratto fu attribuito al pittore della controriforma Scipione Pulzone. Dal Novecento in poi, si sono verificate le prime attribuzioni al Caravaggio. Anche una parte della critica moderna ha avallato la scelta caravaggesca anche se legata ad una fase più acerba del pittore, in quanto, come attestato dal biografo seicentesco Giulio Mancini, Maffeo Barberini fu ritratto dal Caravaggio in più di un'occasione. In esso si ritroviamo già la forza di una raffigurazione impaziente e forte, come la resa del volto impenetrabile e magnetico. Inoltre, il bellissimo vaso trasparente con dei fiori, con l’acqua un po’ opaca per la lunga permanenza, è un altro indizio della maestria del pittore che riproporrà un vaso simile anche in un’altra opera come il Suonatore di Liuto nella versione dell’Hermitage.
Ritratto di Maffeo Barberini (1598) - Olio su tela - 124x90 cm
Collezione privata, Firenze
La storia di questo capolavoro è abbastanza misteriosa. Non si hanno notizie tracciabili prima del suo “ritrovamento” a Roma avvenuto nel 1963, dove il grande critico d’arte Roberto Longhi lo scoprì e l’attribuì al Caravaggio. Il quadro doveva essere rimasto nella collezione Barberini per secoli fino a pervenire sul mercato dell’antiquariato a seguito della dispersione della raccolta avvenuta nel Novecento. A differenza del precedente, questo ritratto ha ricevuto l’accoglienza unanime della critica come autografo di Caravaggio. Attualmente è in una collezione privata a Firenze.
L'opera mostra un giovane Maffeo Barberini in veste di chierico della Camera Apostolica. Maffeo era membro di un'illustre famiglia fiorentina, i Barberini, che poi si trasferirono a Roma. Sarà futuro cardinale e successivamente papa col nome di Urbano VIII.
Questo ritratto non solo colma una lacuna nell’opera di “Caravaggio ritrattista”, un aspetto poco noto, di cui molte opere probabilmente sono andate perdute, ma è anche l’opera che segna una svolta stilistica, col potenziamento dei contrasti tra luce e ombra che si assiste a partire da questo periodo nelle opere del maestro.
L’opera è indubbiamente un capolavoro facente parte della poco conosciuta ritrattistica del maestro. Il protagonista è colto in un momento privato, in un’azione dinamica, è molto espressivo con uno sguardo magnetico, è una figura maestosa ma priva di retorica. Strepitosi come sempre sono i dettagli pittorici che esaltano le mani, il rotolo, la lettera piegata. Come affermava Longhi, con pochi tratti scuri l’autore ci consegna “il ritratto moderno”.
Il quadro non era mai stato esposto in pubblico fino a pochi mesi fa. È stato una delle più belle sorprese viste in questa mostra!
Santa Caterina d’Alessandria (1598-1599) - Olio su tela - 173x133 cm
Museo National Thyssen-Bornemisza, Madrid
In questa sezione della mostra, sale prepotentemente alla ribalta la figura di una modella, probabilmente la celebre cortigiana Fillide Melandroni, che è la protagonista di tre tele mozzafiato: Santa Caterina d'Alessandria, Marta e Maria Maddalena, Giuditta che decapita Oloferne. Anche qui, i curatori della mostra sono riusciti nell’impresa straordinaria di riunire uno accanto all’altro un trittico di capolavori intensi, in cui la maestria dei chiaroscuri dialoga nello spazio della sala in una serie di rimandi quasi ipnotici.
Il dipinto Santa Caterina d’Alessandria fu commissionato dal cardinal Del Monte in onore della madre che portava il nome di Caterina. Gli eredi del cardinale lo cedettero al cardinale Antonio Barberini fino a quando, con la dispersione di parte di questa preziosa collezione, fu venduto nel 1935 al barone Thyssen, quando ancora si credeva che fosse un’opera di Orazio Gentileschi.
Pietro Bellori, biografo di Caravaggio, collocò questo dipinto come punto di transizione dalla fase giovanile – caratterizzata da una pittura nitida e luminosa – alla fase più matura, dove iniziò “ad ingagliardire gli oscuri”, un mutamento stilistico segnato dall’utilizzo più drammatico del chiaro-scuro che avrebbe caratterizzato tutta la produzione successiva.
La Santa è ritratta come una figura di regale maestà, una donna molto bella e nobile, elegantemente vestita con abiti lussuosi, poggiata su di un cuscino damascato, con un sottile cerchietto sulla testa ad indicare la santità. È una rappresentazione dove non c’è trascendenza come raggi di luce divina o altro; al contrario è molto umana e naturale, con uno sguardo interrogativo che denota incertezza. La Santa volge le spalle alla ruota dentata, lo strumento di tortura che la leggenda vuole che si stata spezzata dalla folgore divina, mentre la spada intrisa di sangue, vero strumento del martirio, è stretta delicatamente tra le sue mani. In basso sul cuscino, invece, un simbolo di iconografia tradizionale, ossia la palma del martirio, che va ad incrociare la lama insanguinata della spada con la quale fu decapitata.
Come anticipato, la modella utilizzata è una nota cortigiana senese del suo tempo che viveva a Roma, Fillide Melandroni, che sarà il soggetto anche dei due prossimi quadri.
Caravaggio qui crea un capolavoro che è tra i più belli di quelli esposti in mostra: giustamente e meritatamente i curatori l’hanno presa come riferimento nella locandina della mostra. Personalmente, è uno dei miei capolavori preferiti della mostra.
La bellezza di questo dipinto è così stupefacente che ancora oggi mi chiedo come sia stato possibile che lo Stato italiano, negli anni trenta, abbiamo potuto lasciare il benestare per privarsi di un’opera d’arte di tale grande bellezza: anche se all’epoca si pensava che fosse un’opera di Orazio Gentileschi, questo non giustificherebbe l’alienazione dal nostro patrimonio artistico di un’opera preziosa che splendeva di per sé di luce propria, indipendentemente dalla paternità dell’autore!
Marta e Maria Maddalena (1598-99) - Olio su tela - 100x134,5 cm
Institute of Arts, Detroit
Il dipinto, tradizionalmente interpretato come Marta e Maria Maddalena (o anche Conversione della Maddalena) è stato realizzato intorno al 1598 in un periodo nel quale Caravaggio si trova a vivere sotto la protezione del cardinal Del Monte. Non è nota la circostanza nella quale l’opera venne realizzata e chi fu il committente. Probabilmente potrebbe essere un membro della nobile famiglia Aldobrandini, dato che il quadro rimase nella loro collezione per molto tempo. Nel 1897 apparve nella collezione della famiglia Panzani di Arezzo che vendettero il quadro all’estero. Con successivi passaggi di proprietà, si arriva fino al 1973, quando venne acquistato dal Detroit Institute of Arts.
Il dipinto mostra le sorelle bibliche Marta e Maria nel particolare momento in cui Marta sta convertendo Maria dalla sua vita di peccato per condurla alla fede in Cristo. Marta ha il volto oscurato dall'ombra, si appoggia in avanti ed argomenta con sapienza le sue tesi di fronte alla sorella, che è raffigurata nell'atto di roteare un fiore d'arancio tra le dita, mentre con il braccio sinistro regge uno specchio, simbolo della vanità. Maria è colta nel momento dell'inizio della conversione.
Nella rappresentazione Marta sembra irradiare una luce divina che illumina il volto di Maria Maddalena colta in questo momento di profonda riflessione. Il contrasto tra la severità di Marta e la delicata bellezza di Maria Maddalena evidenzia il dramma interiore della conversione, suggellata dai simboli del cosiddetto matrimonio mistico: il fiore d’arancio nella mano destra l’anello d’oro in quella sinistra.
In questo quadro ci sono ben due modelle che Caravaggio utilizzò in altri suoi quadri. La figura di Maria Maddalena venne interpretata dalla cortigiana Fillide Melandroni, già utilizzata in “Santa Caterina d’Alessandria” e “Giuditta decapita Oloferne”, mentre la modella che posò per la figura di Marta è stata identificata in un'altra cortigiana, Anna Bianchini, che l’artista raffigurò anche in altri due celebri dipinti, la “Maddalena penitente” e “Riposo durante la fuga in Egitto”, non presenti alla mostra.
È un altro bellissimo capolavoro del maestro!
Giuditta decapita Oloferne (1603) - Olio su tela - 145x195 cm
Palazzo Barberini, Roma
In questo celebre dipinto entrato fortemente nell’immaginario collettivo moderno, Caravaggio rappresenta abbastanza fedelmente l'episodio biblico della decapitazione del condottiero assiro-babilonese Oloferne ad opera dell’eroina ebrea Giuditta che, allo scopo di liberare la propria città dal lungo assedio dell’esercito straniero, con uno stratagemma riesce a farsi ammettere nella tenda del generale nemico, con l’obiettivo di sedurlo, ubriacarlo e decapitarlo, portandone via la testa.
 La scena è caratterizzata da una drammaticità teatrale senza precedenti perché il pittore, nel raffigurare un violento assassinio, permette allo spettatore di assistervi da vicino, di osservare i gesti e le emozioni dei protagonisti. Siamo nella tenda di Oloferne, caratterizzata da un drappo rosso che si mischia con l’oscurità. Il caratteristico drappo rosso, che sarà un segno distintivo di molte opere del maestro, appare qui per la prima volta in un suo dipinto.
La scena è caratterizzata da una drammaticità teatrale senza precedenti perché il pittore, nel raffigurare un violento assassinio, permette allo spettatore di assistervi da vicino, di osservare i gesti e le emozioni dei protagonisti. Siamo nella tenda di Oloferne, caratterizzata da un drappo rosso che si mischia con l’oscurità. Il caratteristico drappo rosso, che sarà un segno distintivo di molte opere del maestro, appare qui per la prima volta in un suo dipinto.
La bellezza di Giuditta, vestita a festa con orecchini di perle, è lo strumento di un fato ineluttabile: con una mano tiene fermo per i capelli la testa di Oloferne, stordito dall’ubriacatura, con l’altra mano spinge con forza la lama della spada nel collo del condottiero, mentre il sangue schizza copioso. Colpisce l’incrocio di squadri tra Giuditta e Oloferne, che non è ancora morto e cerca di emettere un urlo che viene strozzato dalla lama della spada. Assiste inorridita alla scena la sua vecchia serva (molto brutta come contraltare alla bellezza di Giuditta) che sorregge con le mani il drappo nel quale andrà conservata la testa e portata via. Più che pittura, sembra una liturgia sacrificale, dove aleggia l’esecuzione di Beatrice Cenci, uno degli episodi più tragici della Roma papalina del Seicento, a cui oltre l’ispirazione sembra che lo stesso Caravaggio abbia assistito alla pubblica decapitazione.
Caravaggio ritrae Giuditta con le sembianze della bella cortigiana Fillide Melandroni, ossia una sua amica-modella che ritroviamo in altri suoi quadri capolavoro (Santa Caterina d’Alessandria, Marta e Maria Maddalena).
La storia di questo capolavoro, come altri del maestro, va raccontata. Il dipinto fu commissionato dal ricco banchiere genovese, il conte Ottavio Costa, residente stabilmente a Roma, che lo raccomandò persino agli eredi nel suo testamento. Con lo scorrere dei secoli però se ne perse la memoria. Nel 1951 Pico Cellini, uno dei massimi restauratori del Novecento, dopo aver visitato la grande mostra dedicata a Caravaggio allestita a Milano da Roberto Longhi, ricordò di aver visto questa tela in un palazzo romano (famiglia Coppi) e la ricollegò allo stile caravaggesco. Risalito al dipinto, che fino ad allora era stato attribuito ad Orazio Gentileschi, il restauratore riuscì a fotografarlo e ne inviò l’immagine a Roberto Longhi, il quale attribuì senza indugio l’opera a Caravaggio. Forte di questa scoperta, la mostra dedicata a Caravaggio fu prorogata appositamente per poter esporre quest’opera “ritrovata”. Un’ulteriore conferma si ebbe quando sul retro del quadro fu trovata la sigla COC, ossia le iniziali del Conte Ottavio Costa. Al fine di non commettere gli errori del passato, che portarono alla dispersione di parte del grande patrimonio pittorico di Caravaggio, dopo una lunga trattativa, finalmente lo Stato italiano l’acquistò nel 1971 e lo collocò a Palazzo Barberini.
Rientra tra i capolavori assoluti del maestro.
SALA 3: DRAMMA SACRO TRA ROMA E NAPOLI
In questa sala, sono le opere religiose a prendere il sopravvento. Essa espone, tra l’altro, l'Ecce Homo di recente attribuzione (2021), l’ultimo dipinto scoperto sul Caravaggio.
San Francesco in meditazione (1605) - Olio su tela - 128x97 cm
Palazzo Barberini, Roma
Il dipinto è uno dei numerosi dilemmi caravaggeschi non ancora completamente risolti: ci sono due opere identiche che si contendono il titolo di opera originale: una si trova a Palazzo Barberini, l’altra nella chiesa dei Cappuccini di Santa Maria Immacolata di Via Veneto, dunque a poca distanza tra di loro.
Dal punto di vista storico, è certificato che il San Francesco in meditazione di Palazzo Barberini venne donato nel 1609 dal cardinale Pietro Aldobrandini alla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano. Successivamente si persero le tracce, fino a che l’opera non fu “riconosciuta” dalla critica negli anni sessanta del Novecento. La versione oggi a Palazzo Barberini è qualitativamente migliore e si propende che sia l’originale, anche se potrebbe essere possibile che la versione nella chiesa dei Cappuccini sia una copia fatta o supervisionata dallo stesso Caravaggio.
San Francesco è ritratto in un interno, probabilmente una grotta o una costruzione estremamente rustica. Intorno a lui non vi è nulla che possa distrarre lo sguardo dello spettatore dal Santo. Quest’ultimo, colpito da una luce che dà risalto all’orecchio destro ed al naso, rossi per il freddo, scruta un teschio illuminato che tiene tra le mani.
Indossa un umile saio, ormai logoro, che mostra buchi e rattoppi. A terra c’è una semplice croce che poggia su un tronco di legno. È un’immagine di grande umiltà, nello spirito della controriforma. È una composizione completamente all’opposto di quel San Francesco in Estasi che il Caravaggio aveva dipinto dieci anni prima.
Cena in Emmaus (1606) - Olio su tela - 141×175 cm
Pinacoteca di Brera, Milano
Il dipinto riprende un suo precedente di pari soggetto che Caravaggio aveva creato nel 1602 e che si trova nelle collezioni della National Gallery di Londra. Il quadro di Milano è sicuramente più sobrio e asciutto rispetto al capolavoro di Londra poiché nasce in un diverso momento (1606) e soprattutto da un diverso stato d’animo del maestro: si ritiene che questo quadro sia stato il primo dipinto realizzato dopo la sua precipitosa fuga da Roma per sfuggire alla condanna capitale. L’artista si era rifugiato nei feudi di Palestrina della potente famiglia romana dei Colonna. Pur protetto, aveva però bisogno di soldi per spostarsi al di fuori dello stato pontificio, dove era sempre potenzialmente in pericolo. Per questo si rimise subito a dipingere. Uno dei suoi biografi, Pietro Bellori, racconta che fece quest’opera su commissione del marchese Patrizi di Roma, che in questo modo lo sostenne.
La vicenda evangelica rappresentata nel dipinto è famosa. Nei giorni successivi alla Pasqua, due discepoli sono in cammino sulla via per Emmaus ed incontrano un viandante sconosciuto che si affianca a loro per parlare insieme. Raggiunto il posto, i due non lo lasciano andare per la sua strada perché lo invitano a cenare insieme. Il quadro riprende l’attimo in cui lo straniero, durante la cena, spezza il pane benedicendolo: a quel punto gli occhi dei due discepoli “si aprono” e lo riconoscono: è il Cristo Risorto. Il discepolo alla sinistra del maestro sta per sobbalzare dalla sedia mentre quello a destra, ritratto di spalle, allarga le braccia per la sorpresa e la gioia d’averlo riconosciuto.
Questo quadro segna una svolta stilistica nella sua produzione artistica: i colori diventano meno brillanti, sono poveri e terrosi. Si apre una fase nuova della sua pittura, che caratterizzerà tutte le sue opere successive, ossia quelle nate dall’esilio e dalla fuga da Roma, dalla quale non riuscirà più a ritornare.
Davide con la Testa di Golia (1609/10) - olio su tela - 125x100 cm
Galleria Borghese, Roma
È uno dei quadri più famosi del Caravaggio, dipinto durante il suo ultimo soggiorno a Napoli prima d’imbarcarsi per Roma.
È noto che a Napoli l’artista fu raggiunto dalla notizia che il cardinale Scipione Borghese, suo grande ammiratore e collezionista, stava caldeggiando il rilascio della grazia allo zio, Papa Paolo V. Come segno di ringraziamento, Caravaggio gli spedì questo quadro, con la promessa di consegnare altre opere al suo arrivo a Roma: erano in pratica il prezzo della fine delle sue tormentate peregrinazioni.
L’ossessione della sua decapitazione, a seguito della pena capitale che lo aveva colpito all’indomani dell’omicidio commesso a Roma, lo tormentava da molto tempo insieme alla volontà di espiazione della colpa e di speranza del proprio riscatto.
Il quadro evidenza un Davide che emerge dall’oscurità illuminato da una luce accecante che tiene in mano la testa di Golia, appena decapitato. È pacifico il fatto che l’immagine della testa di Golia è l’autoritratto del Caravaggio.
Secondo un’interpretazione moderna, anche l’immagine di Davide sarebbe quella del pittore da adolescente, volendo in questo modo l’artista sottolineare come il giovane senza peccato uccide il vecchio peccatore come in una sorta di espiazione e di riscatto.
Flagellazione di Cristo (1607/08) - Olio su tela - 286x213 cm
Museo di Capodimonte, Napoli
È considerata una delle opere più significative della sua piena maturità artistica. Il dipinto fu commissionato dal nobile napoletano Tommaso de’ Franchis per adornare la cappella di famiglia situata nella chiesa di San Domenico maggiore nel centro storico di Napoli. Una volta realizzata, la tela fu collocata sull'altare maggiore della cappella. Fu tra i primi dipinti compiuti dal maestro una volta giunto a Napoli. Come tutte le opere di Caravaggio a Napoli, fu subito apprezzata dai suoi contemporanei.
Uno storico napoletano del Seicento, Carlo de Lellis, in una nota la descrisse come «la più bell’opera che già mai fatto habbia questo illustre dipintore». Il quadro rimase in chiesa fino al 1980 quando, a seguito del terremoto dell'Irpinia, la Flagellazione venne trasferita per ragioni di sicurezza nel Museo di Capodimonte. I dettagli dei corpi che emergono dal buio assoluto sono stupefacenti, grazie ad una luce quasi accecante, che sottolinea con grande drammaticità l'evento che il dipinto racconta.
La colonna a cui è incatenato il Cristo si intravede appena mentre la luce illumina potente il volto, il busto di Cristo e gli aguzzini, che sono vestiti non come soldati romani ma con abiti seicenteschi. Il dipinto ricorda, nella costruzione dell’impianto scenografico, il Martirio di San Pietro nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma. Ma mentre in quest’ultima rappresentazione, gli aguzzini danno più l’idea di semplici lavoratori che stanno lì per fare il proprio dovere, gli aguzzini della Flagellazione, di cui due all’impiedi e uno accosciato, danno l’impressione di essere consapevoli della brutalità e della sofferenza che infliggono alla vittima.
È un altro capolavoro del maestro che rientra tra i miei preferiti.
Ecce Homo (1606-07) - Olio su tela – 111x85 cm
Museo del Prado, Madrid
Uno dei grandi protagonisti della mostra è stato sicuramente il dipinto Ecce Homo di recentissima attribuzione, che torna in Italia dopo quattro secoli.
Singolare è la storia della sua “riscoperta. Nell'aprile 2021 un'opera appartenente alla cerchia di un seguace spagnolo di Caravaggio, Jusepe de Ribera, viene messa all’asta a Madrid al prezzo base di 1.500 euro.
Su segnalazione del Museo del Prado, il quadro viene ritirato poiché alcuni esperti, soprattutto critici d’arte italiani come Sgarbi e Terzaghi, ritengono che sia un probabile quadro di Caravaggio.
Il restauro avvenuto nel 2023 ha confermato la qualità e lo stile pittorico del maestro. I critici ritengono che l’opera sia stata eseguita nel periodo napoletano per il viceré di Napoli, Garcia Avellaneda, dato che è documentato nella sua collezione personale. Poi dell’opera se ne perde la memoria fino a quando non emerge dalla recente asta madrilena.
In quest’opera c’è un singolare intreccio tra un modello “idealizzato” utilizzato per la figura di Gesù e tra modelli “reali” utilizzati per gli altri personaggi. Nonostante ciò, colpisce proprio la figura del Cristo la cui sofferenza è reale, quasi palpabile. La pittura si fa essenziale, scarna, anche se la luce illumina potente il corpo dolente ed il volto remissivo ma non vinto.
In primo piano Pilato si sporge dal balcone per mostrare al pubblico: ecco l’uomo! Dietro Gesù, colpisce lo sguardo di un giovane aguzzino con la bocca spalancata, in un’espressione teatrale, mentre copre con un manto rosso le spalle del Cristo. A differenza di quest’ultimo, gli altri due personaggi, Pilato e l’aguzzino, sono avvolti nell’ombra.
Il quadro ritrovato a Madrid scuote certezze e accende dispute, ci pone davanti a un Cristo la cui sofferenza è quasi palpabile. La pittura si fa essenziale, scarna ma sempre potente ed espressiva: è un capolavoro ritrovato!
Stranamente, alla mostra c’erano solo due quadri che non si potevano fotografare da vicino, l’Ecce Homo e la Cattura di Cristo. Non si conoscono e non si comprendono le ragioni di questa limitazione, visto che grazie ai moderni telefonini è possibile effettuare splendide foto senza flash e senza danneggiare i capolavori che, in quanto tali, vanno al contrario fatti conoscere ad un pubblico più ampio possibile, soprattutto a quelli meno fortunati che non hanno potuto venire ad ammirare dal vivo questi capolavori, patrimonio di tutta l’umanità.
San Giovanni Battista nel deserto (1604) - Olio su tela – 173x133 cm
Museo Atkins – Kansas City, USA
Il dipinto fu commissionato nel 1604 dal banchiere genovese Ottavio Costa, per il quale il pittore aveva già eseguito Giuditta e Oloferne e Marta e Maria Maddalena. Costa voleva che fungesse da pala d'altare per un piccolo oratorio in proprio feudo un villaggio nei pressi di Albenga, sulla Riviera ligure), ma gli piacque al punto che lo sistemò nella collezione della sua dimora romana mentre spedì una copia all'oratorio. Dopo la dispersione della sua raccolta, a seguitp di vari passaggi di proprietà, l’opera è oggi conservata nel Museo Nelson-Atkins di Kansas City.
La raffigurazione del Battista nel deserto è un quadro di grande monumentalità e si discosta dalla tradizionale raffigurazione del santo nel deserto (manca l’agnello) che è in profonda meditazione. La posizione anatomica del soggetto, colo viso quasi imbronciato, col dorso ricurvo e le gambe divaricate, coperto dal caratteristico mantello rosso tipico di Caravaggio, s’ispira sia a modelli Michelangeleschi che a quelli classici (Dorso del Belvedere). È di una straordinaria qualità pittorica, al punto che è per me il mio San Giovanni Battista preferito dipinto dal maestro.
Esistono anche due copie antiche di questo magnifico dipinto, una è conservata nel Museo di Capodimonte di Napoli mentre la copia che spedì il banchiere Costa all’oratorio ligure oggi è conservata nel museo diocesano di Albenga.
San Giovanni Battista (1604) - Olio su tela - 94x131 cm
Galleria Barberini-Corsini, Roma
Figlio di Elisabetta che era a sua volta cugina di Maria, San Giovanni battista era dunque un parente di Gesù. Come si racconta nel Vangelo, la sua opera fu quella di preparare la strada alla predicazione del Cristo e fu colui che lo battezzò nel fiume Giordano.
San Giovanni Battista è stato sicuramente il soggetto più eseguito dall’artista, ne realizzò almeno otto versioni in momenti diversi della sua vita. Caravaggio rappresentò spesso la figura di Giovanni come un giovane solo nel deserto, all’epoca non era molto comune, ma nemmeno del tutto sconosciuta. Tale raffigurazione si basava su una breve affermazione del Vangelo di Luca: «il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele».
Intorno al 1604 Caravaggio dipinse due tele che raffiguravano San Giovanni Battista. La prima fu quella dipinta per il conte Ottavio Costa che, a seguito della dispersione della sua collezione antica, oggi si trova nel museo di Kansas City negli USA. La seconda fu questa opera che oggi è collocata nella Galleria nazionale d'arte Antica. Come il San Giovanni di Kansas City, la figura è stata spogliata dei consueti attributi che alluderebbero all'identità del santo, tra cui il tradizionale "mantello con peli di cammello", e vi è appena accennata la croce con bastoncini di canna. Sulla sinistra si staglia il tronco di un cipresso. Il santo è sbilanciato a destra mentre guarda verso sinistra ed è avvolto dal classico drappo rosso, tipico del Caravaggio.
Caravaggio non è stato il primo artista ad aver raffigurato il Battista come un nudo maschile criptico, cioè che si tende a nascondere, ma vi ha introdotto una nuova nota di realismo e drammaticità. Il suo Battista ha le mani screpolate, rugose per la fatica, il suo torso pallido contrasta con l'oscurità dello sfondo. Questo perché come modello per questo quadro, il Caravaggio prende un vero ragazzo che si spoglia per la posa, al contrario ad esempio del San Giovanni Battista di Raffaello, che è una figura astratta.
Cattura di Cristo (1603) - Olio su tela - 136x170 cm
National Gallery of Ireland, Dublino
La Cattura di Cristo (detta anche Presa di Cristo nell'orto) è un’opera realizzata intorno al 1603, quando ormai Caravaggio si era affermato come pittore nella Roma papalina.
Il dipinto ha una storia singolare. Sicuramente fu commissionata dal nobile romano Ciriaco Mattei. I suoi eredi vendettero il quadro ma col tempo se ne persero le tracce. Attualmente sono due le versioni che si contendono il titolo di opera originale, anche se entrambe sono state attribuite a Caravaggio, con qualche riserva critica.
La prima è quella esposta alla mostra. La tela riapparve agli inizi dell’Ottocento in Gran Bretagna. Attraverso altre compravendite, arrivò nella proprietà di una nobile irlandese che la donò alla comunità gesuita irlandese che, a sua volta, l’ha dato in prestito a tempo indeterminato alla National Gallery of Ireland di Dublino;
La seconda versione invece fu scoperta da Roberto Longhi nella collezione privata della famiglia Sannini di Firenze, anche se il grande critico d’arte la riteneva un’opera di un anonimo copista di Caravaggio e come tale fu ancora acquistata nel 2003 dall'antiquario Mario Bigetti. Quest’ultimo sottopose il dipinto ad un restauro e ad approfonditi esami radiografici, dove emersero alcuni pentimenti dell’autore, per cui sembrerebbe che questa copia sia la prima creata dal maestro mentre quella di Dublino sarebbe una versione successiva o contemporanea della stessa, dato che il dipinto ebbe un discreto successo tra i suoi estimatori.
In questo capolavoro, Caravaggio mette in scena una rappresentazione articolata e complessa del celebre episodio evangelico. Il fulcro della scena è il bacio di Giuda, il simbolico gesto che sancisce il tradimento ai danni del maestro: è il segnale dato alle guardie, raffigurate in armature seicentesche, affinché lo catturino.
All’estrema sinistra c’è il discepolo Giovanni che, disperato, si sta liberando del mantello per darsi alla fuga dopo che una guardia l’ha afferrato per lo stesso. Dietro le guardie, c’è un personaggio che ha in mano una lanterna ed assiste alla cattura: la critica moderna ritiene che sia un autoritratto dello stesso Caravaggio. Al centro domina la figura del Cristo che è un'isola di silenzio in tutto quel caos. La potente luce lo elegge vittima sacrificale e ne illumina la sconvolgente forza morale dell’accettazione.
È un altro capolavoro del maestro!
SALA 4: ULTIMO ATTO, IL CANTO DEL CIGNO
Questa sala espone l'ultima tappa del viaggio terreno e artistico del Caravaggio, che si congeda da noi con un velo di tristezza e malinconia.
Ritratto di Antonio Martelli (1608-09) - Olio si tela - 118,5x95 cm
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, Firenze
Il Ritratto di Cavaliere di Malta ha la severità inquieta dell'esilio, lo sguardo fiero del raffigurato ma segnato dall’età. La grande qualità pittorica del ritratto, sebbene costruito con una pittura rapida e vivace, che indaga sull’espressione del volto con pennellate veloci, come è caratteristica dell’ultima parte della sua carriera dove il suo dramma personale si fa più cupo, ha raccolto il consenso unanime della critica moderna sulla paternità dell’opera.
Non si hanno notizie antiche di questo quadro e di come giunse nelle collezioni dei Medici di Firenze. Un altro dubbio è l’identità del Cavaliere di Malta, in un primo momento identificato come il gran maestro dell’ordine mentre solo recentemente si è fatta avanti l'ipotesi che si tratti di Antonio Martelli, cavaliere di Malta, ritratto all'età di circa settanta anni.
Il pittore fu molto legato a lui, tanto da far pensare che la fuga di Caravaggio da Malta sia stata possibile grazie all'aiuto del Martelli. Riferimenti documentali hanno poi definitivamente confermato questa ipotesi.
Il dipinto appare incompiuto nello sfondo e nei particolari in basso della figura: ipotesi, questa, che farebbe pensare a quest'opera come l'ultima dipinta a Malta, prima della nuova precipitosa fuga, oppure dipinta quando Caravaggio arrivò successivamente a Messina, dove era presente lo stesso Martelli.
San Giovanni Battista (1609-10) - olio su tela - 159x124 cm
Villa Borghese, Roma
San Giovanni Battista in questo dipinto è raffigurato molto giovane. L’opera fu completata dal maestro poco prima della sua morte. Quando lasciò Napoli in feluca per ritornare a Roma, il pittore portò con sé l’opera sperando di presentarla personalmente in dono al cardinale Scipione Borghese, in segno di gratitudine per aver promosso un decreto papale per la sua grazia. Purtroppo Caravaggio non ci arrivò mai a Roma, dato che morì in circostanze misteriose proprio durante quel viaggio della speranza.
San Giovanni Battista, figlio di Elisabetta che era cugina di Maria, è raffigurato giovane in una posa semplice e rilassata, con lo sguardo pensieroso. Si ha la sensazione che l’artista abbia creato un ritratto di un pastorello appoggiato sullo sfondo di un tessuto drappeggiato di un ricco colore rosso, colore che allude al sangue versato durante il suo martirio. Nella mano sinistra ha un'esile canna, che è un riferimento alla vita di penitenza e di preghiera vissuta da Giovanni nel deserto. Alla sua destra, nella penombra, s’intravede un montone, simbolo della redenzione dell’uomo attraverso il sacrificio di Cristo.
Martirio di Sant’Orsola (1610) - Olio su tela - 143x189 cm
Gallerie d’Italia, Napoli
È l’ultimo capolavoro dipinto dal maestro prima della sua prematura scomparsa. Il dipinto fu commissionato a Napoli dal banchiere genovese Marcantonio Doria prima che il pittore s’imbarcasse per il suo viaggio della speranza a Roma. Una volta eseguito il quadro, al fine di spedirlo velocemente al committente, lo spedizioniere mise incautamente ad essiccare il dipinto ai raggi del sole e questo sicuramente gli fece perdere in parte la qualità dei colori. Restò per secoli in mano alla famiglia genovese fino a che non fu ereditato da un ramo secondario dei Doria residente a Napoli, nel palazzo Doria D’Angri di via Toledo. Era destino che l’opera doveva ritornare nel suo luogo d’origine.
Tuttavia, negli ultimi passaggi ereditari se ne perse la memoria dell’autore e per molto tempo si credette un’opera di Mattia Preti, un pittore caravaggesco. Nel 1973 la Banca Commerciale Italiana (oggi Banca Intesa) l’acquistò quando la paternità dell’opera era ancora incerta e fu naturalmente un grande affare. Già dai successivi lavori di restauro dell'opera emersero nuove informazioni che iniziarono a chiarire la storia. Tra queste informazioni vi fu quella della comparsa sul retro della stoffa di una scritta antica «D. Michel Angelo da Caravagio 1616 M.A.D.», dove l'acronimo sta ad indicare il nome del committente Marco Antonio Doria mentre l'anno fu erroneamente trascritto, dato che avrebbe dovuto essere il 1610.
Nel 1980 uno storico d’arte napoletano, Vincenzo Pacelli, riuscì a rintracciare la lettera del 1610 con la quale il mediatore napoletano spediva ai Doria di Genova il quadro, attestandone così l’assoluta certezza della paternità al Caravaggio.
Nel Martirio di Sant’Orsola l’artista rappresenta il momento, estrapolato dalla tradizione del IV secolo, in cui Attila (il terribile guerriero unno denominato il “flagello di Dio”) uccide la giovane Orsola con una freccia, dopo che lei ha rifiutato di sposarlo. La scena è ambientata nella tenda del capo unno ed è caratterizzata da una moderna dinamicità: da sinistra, Attila, raffigurato in abiti secenteschi, sembra essersi già pentito di aver scoccato la freccia mortale dal proprio arco tenuto ancora in pugno, mentre Orsola, rivolta su sé stessa, osserva l’arma e le prime gocce di sangue sgorgare dal suo petto. Il colore biancastro e spettrale della sua pelle, diverso da quello di tutti gli altri personaggi, prelude già alla sua triste ed imminente fine.
Tra i tre barbari presenti sulla scena, anche loro vestiti in abiti seicenteschi e che sembrano sorpresi dal colpo improvviso scagliato dal loro capo, si scorge a destra il volto reclinato e dolorante di uno di essi, che è visibilmente un autoritratto del Caravaggio. In questo modo, si raffigura sofferente, come se subisse anche lui la violenza del colpo insieme alla giovane martire.
L’opera è il drammatico canto del cigno del maestro, il suo ultimo grande capolavoro, un altro dei miei preferiti.
La mostra si congeda mirabilmente in questo modo. All’uscita si resta raggianti, grati per aver avuto la fortuna di aver assistito ad un evento davvero epocale!
Antonio Pezzullo
POSTILLA
Le sorprese non finiscono qui. La mostra ha un suo pendant, un corollario di grande fascino, in quanto col biglietto d’ingresso si ha il diritto di vedere, in esclusiva, una rarissima opera di Caravaggio che è visitabile eccezionalmente in occasione dell’evento: Giove Nettuno e Plutone nel Casino dell’Aurora di Villa Ludovisi a Roma. Idealmente, costituisce l’opera numero 25 di questa strepitosa mostra.
Giove, Nettuno e Plutone - Dipinto murale di olio su muro (1599)
Casino dell’Aurora di Villa Ludovisi, Roma
Si tratta di un unicum nella produzione di Caravaggio: è l’unico dipinto murale, eseguito a olio su muro, che gli fu commissionato dal cardinale Francesco Maria Del Monte, il suo primo facoltoso mecenate romano, al servizio del quale il Merisi era entrato nel 1597.
Giove, Nettuno e Plutone era destinato a un ambiente piuttosto speciale del Casino costruito nel 1570, ovvero il «camerino della distilleria» (così lo definisce Pietro Bellori, tra i primi biografi dell’artista), una sorta di gabinetto alchemico nel quale il cardinale si dilettava, essendo egli «studioso di medicamenti chimici». L’iconologia del dipinto è complessa e legata all’alchimia (come d'altronde l'intero ambiente che lo ospita): in particolare Giove, Nettuno e Plutone sono divinità tradizionalmente associate alle tre fasi della pratica alchemica, attraverso le quali, partendo da una materia grezza, si ricava la pietra filosofale.
Per poterlo dipingere, Caravaggio utilizzò la tecnica del “sotto in su” per creare l’illusione che le figure stiano fluttuando in aria. Per raffigurare la scena, utilizzò un grande specchio piano sul quale salì lui stesso raffigurandosi nudo, così che Giove Nettuno e Plutone in pratica sono tre autoritratti!
Sullo sfondo di un cielo solcato da nuvole, si staglia al centro una sfera luminosa e traslucida. Da una parte c’è Giove accompagnato dall’aquila mentre tende la mano verso la sfera centrale.
 Dall’altra c’è Nettuno (forse un autoritratto di Caravaggio), il dio del mare con il cavallo “marino” dalle zampe palmate, e Plutone, il dio degli inferi con i genitali in bella vista scortato da Cerbero, il temibile cane a tre teste.
Dall’altra c’è Nettuno (forse un autoritratto di Caravaggio), il dio del mare con il cavallo “marino” dalle zampe palmate, e Plutone, il dio degli inferi con i genitali in bella vista scortato da Cerbero, il temibile cane a tre teste.
Giove, Nettuno e Plutone, gli dei dell’antichità, rappresentano i tre elementi principali: rispettivamente aria, acqua e terra. In alchimia i tre elementi corrispondo ai tre stati della materia: gassoso, liquido e solido. Caravaggio ritrae coerentemente soltanto tre dei quattro elementi (esclude il fuoco), dando ad ogni elemento le fattezze di un dio dell’antichità.
È un capolavoro poco noto che merita di essere riscoperto e conosciuto al grande pubblico.
Antonio Pezzullo
|