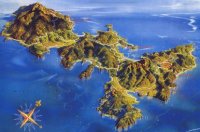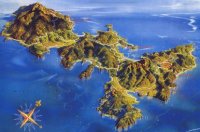Gli scritti di Antonio Pezzullo
|
|
IL CASO GALILEO GALILEI
“E pur si muove!”
Quando nel 1632 papa Urbano VIII convocò a Roma il matematico ed astronomo Galileo Galilei per sottoporre il suo “caso” al Santo Uffizio e porre così fine al dibattito in atto da decenni sulla diffusione delle teorie eliocentriche di Copernico, egli era già considerato in tutta Europa come uno dei più famosi eruditi del suo tempo.
Per capire come si era arrivati a questa situazione, occorre partire dagli inizi.

|
|
Pisa - Casa natale di Galileo Galilei
|
|
|
GLI INIZI
Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564, primo di sette figli di Vincenzo Galilei e Giulia Ammannati. Una volta compiuto gli studi di base, visto la predisposizione allo studio del ragazzo, il padre lo iscrisse inizialmente agli studi di medicina presso l'Università di Pisa, allo scopo di fargli fare una carriera che potesse procuragli dei lucrosi guadagni. Tuttavia, nel 1583 il giovane scelse di studiare e specializzarsi in matematica. Ad ispirarlo e fargli da insegnante fu Ostilio Ricci (un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia) il quale riteneva che la matematica fosse una scienza non astratta ma utile per risolvere i problemi pratici, tra cui quelli legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Grazie al rigoroso studio della matematica, Galileo apprese il fondamentale concetto dell'importanza della precisione nell'osservazione dei dati, una metodologia che avrebbe poi sempre applicato alle sue future ricerche.
A Pisa approfondì gli studi anche della fisica. Dopo il completamento degli studi, nel 1589 ebbe subito un contratto triennale d’insegnamento della matematica all’Università di Pisa. In questo periodo, fece la sua prima scoperta scientifica: si racconta che, osservando una lampada posta sul soffitto della cattedrale di Pisa, scoprì “l'isocronismo” del pendolo, ossia che la durata del periodo di oscillazione, al variare dell’ampiezza delle oscillazioni, rimane sempre la stessa. Fu una scoperta fondamentale per la futura costruzione degli orologi a pendolo.
IL PERIODO PADOVANO
Nel 1592 venne chiamato presso l'università di Padova dove fu docente di matematica fino al 1610. I diciotto anni trascorsi nella città veneta, allora facente parte della Serenissima, furono definiti da Galileo «i migliori di tutta la mia età».
Nello suo studio di Padova, Galileo si creò una piccola officina nella quale eseguiva vari esperimenti e fabbricava diversi strumenti che vendeva per arrotondare lo stipendio: qui inventò nel 1593 la macchina per portare l’acqua a livelli più alti, che fu utilizzata a Venezia.

|
|
Galileo presenta il cannocchiale al Doge
|
|
|
Nel 1604 apparve nei cieli europei una “nuova stella”, luminosissima, la cosiddetta supernova di Keplero, dato che quest’ultimo erudito olandese, suo contemporaneo, la studiò per ben due anni.
Grazie al rinnovato interesse per le stelle indotto dalla supernova, Galileo ne approfittò per creare oroscopi a pagamento, ma soprattutto per costruire e perfezionare tra 1604 e 1609 il famoso cannocchiale, uno strumento inventato in Olanda ma usato da Galileo per la prima volta con la precisa finalità di osservare le stelle.
Nel 1609 Galileo fece una dimostrazione delle potenzialità del cannocchiale al Doge di Venezia ed alla sua corte in cima al campanile di San Marco. I risultati furono così strabilianti che gli fu offerto una cattedra di matematica a vita col doppio dello stipendio!
Sopraffatto dalle possibilità e dagli inattesi riconoscimenti che il suo cannocchiale gli offriva, Galileo si mise all’opera per mettere nero su bianco sulle sue spettacolari scoperte, che aveva ottenuto grazie ad esso. La Luna, Giove e la Via Lattea furono i primi oggetti celesti verso i quali Galileo puntò il cannocchiale scoprendo in essi caratteristiche che mai uomo prima di lui aveva visto. Galileo aveva usato la torre del castello di Padova come luogo ideale di osservazione che, ancora oggi, i padovani chiamano “la specola” ed è la sede del moderno osservatorio astronomico della città.
IL “SIDEREUS NUNCIUS”
Le nuove scoperte vennero pubblicate nel 1611 nel suo rivoluzionario scritto “Sidereus Nuncius”, ritenuto ancora oggi l’incunabolo dell’astronomia moderna, opera che Galileo inviò al granduca di Toscana Cosimo II de Medici anche allo scopo di ritornare nella sua terra e che gli valse la nomina di matematico e filosofo ufficiale del Ducato di Toscana, con un salario annuo di mille scudi. «Così infinitamente rendo grazie a Dio che si sia compiaciuto di far me solo primo osservatore di cosa ammiranda e tenuta a tutti i secoli occulta». In questo modo, Galileo annunciava al mondo per la prima volta:
-le irregolarità della superficie lunare, che fino ad allora si riteneva fosse liscia, dovute alla presenza di crateri, montagne e gole;
-la constatazione che la Via Lattea raccoglieva una pluralità di singole stelle lontanissime, che allargavano i confini dell'universo;
-la scoperta dei quattro maggiori satelliti di Giove, che chiamò Medicea Sidera. Ancora oggi, sono conosciuti come i satelliti medicei (o galileiani), ossia: Io, Callisto, Europa e Ganimede. Il fatto che questi 4 corpi celesti ruotavano intorno ad un altro pianeta si discostava dalla teoria vigente (tolemaica o geocentrica) che tutto ruotasse intorno alla Terra, posta al centro dell’Universo.
-l’osservazione delle fasi di luce del pianeta Venere, dove aveva dedotto che era Venere a girare attorno al Sole e non attorno alla Terra, proprio come accadeva all’interno del sistema eliocentrico di Copernico.

|
|
Ritratto di Niccolò Copernico
|
|
|
L’atteggiamento iniziale che tenne la Chiesa nei confronti delle sue scoperte fu benevolo. Nel suo viaggio a Roma del 1611, Galileo fu ben accolto da papa Paolo V e dai suoi cardinali. Dopo aver argomentato le sue teorie, ottenne l'appoggio dei gesuiti (considerati le maggiori autorità scientifiche del tempo) che ne proposero l'iscrizione all'Accademia dei Lincei, la prima accademia scientifica al mondo.
Nel 1613 pubblicò “Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti”, col quale scrutò il Sole vedendovi delle macchie in movimento (scoprendo le cosiddette macchie solari).
Man mano che faceva le sue eccezionali scoperte, Galileo si rendeva conto che acquisiva sempre più prove sulla veridicità sia delle teorie di Giovanni Keplero sui movimenti dei pianeti (tra cui quella in base alla quale la Terra compiva su sé stessa un moto di rotazione), sia della rivoluzionaria teoria eliocentrica enunciata nel “De revolutionibus orbium coelestium” del 1543 dall'astronomo polacco Niccolò Copernico, per cui non la Terra, ma il Sole si trovava al centro del sistema, con i pianeti che gli giravano attorno con un moto di rivoluzione.
LA DISPUTA CON LA CHIESA
Le sensazionali scoperte astronomiche di Galileo attirarono ben presto non solo le ammirazioni da tutta Europa ma anche le prime invidie dei suoi oppositori e, soprattutto, le “attenzioni” della Chiesa.
Nel 1614 a Firenze il frate domenicano Tommaso Caccini lanciò contro i matematici moderni, e in particolare contro Galileo, l'accusa di contraddire le Sacre Scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane. Il clima iniziava a farsi teso per i sostenitori di queste teorie e nel 1616 i teologi della Chiesa di Roma affermarono che le idee copernicane erano eretiche perché contraddicevano i passi delle Sacre Scritture e le opinioni dei Padri della Chiesa.
Galileo espresse il suo pensiero in una serie di lettere scritte tra 1613 e 1616, denominate Lettere Copernicane, inviate a diverse autorità dell’epoca.
In queste lettere Galileo cercava di spiegare come la Bibbia avesse un carattere morale e salvifico e non scientifico e si preoccupò di chiarire l'approccio che si doveva avere nelle Scienze. Le discussioni di carattere scientifico dovevano basarsi sulla creazione di un'ipotesi che nasceva dalla teoria e che trovava conferma nell'osservazione diretta della realtà naturale.
In estrema sintesi, secondo Galileo il metodo da seguire per conoscere la realtà naturale era il cosiddetto metodo scientifico o sperimentale, che possiamo riassumere nel seguente diagramma:
Con estrema lucidità, il grande scienziato cercava di conciliare Scienza e Fede ma nonostante questo, per l’aumento dell’opposizioni di coloro che non volevano o non potevano assecondare le sue spiegazioni, si trovò suo malgrado sempre più spesso vittima del fuoco incrociato dei critici che lo accusavano di ateismo e di un comportamento dannoso per la Chiesa.
La contesa accesasi contro la sua persona trovò, nel 1616, una conclusione temporanea con un’ammonizione verbale: la Chiesa gli impose di astenersi dal difendere pubblicamente le idee copernicane. In quello stesso anno, il libro De revolutionibus di Copernico fu messo all’indice tra i libri proibiti fino a che non fosse stato corretto. Col senno del poi, si può dire che a Galileo gli andò bene perché il più autorevole rappresentante del Sant’Uffizio di allora era il famoso cardinale Bellarmino, ossia l’inquisitore che, anni prima, aveva mandato al rogo per eresia il filosofo Giordano Bruno.
Nel frattempo, anche gli eventi naturali contribuivano ad accrescere sempre più gli interessi per l’astronomia. Dopo la supernova di qualche anno prima, nel 1618 comparvero in cielo ben tre comete, fatto che stimolò gli studi degli astronomi di tutta Europa.
Nel 1622 Galileo scrisse “Il saggiatore”, uno studio appunto sulle comete, nel quale ribadiva un concetto importante: «la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri son triangoli, cerchi, e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto».
Galileo mostrava una grandezza di pensiero talmente avanti da non essere compresa dalla maggior parte degli uomini del suo tempo.

|
|
Un’antica copertina del libro
|
|
|
IL CELEBRE DIALOGO
Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al nuovo papa Urbano VIII (il cardinale Maffeo Barberini, da anni suo estimatore) e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano, ma nelle ben sei udienze concessegli dal papa non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Tuttavia riuscì ad ottenere la possibilità di scrivere una nuova opera sull’argomento a condizione che non parlasse di Sacre scritture e considerasse il sistema copernicano solo come un’ipotesi di discussione e non una certezza.
Dopo un lungo e tormentato percorso, finalmente nel 1632 vide la luce il suo celebre “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”.
Galileo adottò l’espediente letterario di un dialogo immaginario, ambientato a Venezia, con tre personaggi ormai scomparsi: l’amico padovano Giovanni Sagredo era il moderatore, l’amico e nobile fiorentino Filippo Salviati era il sostenitore della teoria copernicana mentre il sostenitore della teoria tolemaica era Simplicio, un filosofo e matematico aristotelico del V secolo. Pur ispirato ai celebri Dialoghi di Platone, questo stile consentiva la libera ricerca della verità mediate il confronto delle diverse posizioni, attraverso l’originale struttura del dialogo a tre. L’espediente rispondeva all’esigenza di allargare quanto più possibile lo spazio di divulgazione delle sue teorie ed il fatto che l’avesse scritto pure in italiano volgare (e non in latino) serviva a rendere il testo accessibile a molte più persone, con un target quasi popolare.
Anche se apparentemente neutrale, l’opera sottolineava in pratica la plausibilità del nuovo modello copernicano a discapito di quello tolemaico, valido da duemila anni. In questa ideale partita tra le due “squadre”, non si era verificato il pareggio: il passato aveva perso mentre il futuro aveva vinto. Del resto, Galileo non era solo un genio nello scoprire e capire le cose del mondo ma aveva anche la grande qualità di saperle spiegare molto bene, grazie alla sua prosa d’eccellente scrittore.
L’arguzia e l’amore per la verità delle sue scoperte alla fine avevano prevalso sull’opportuna prudenza e moderazione. Anche per effetto del clamoroso successo di pubblico che il suo libro ebbe in Italia ed in Europa, Galileo aveva divulgato su vasta scala proprio quello che la Chiesa gli aveva chiesto di non divulgare.
Papa Urbano VIII, che come abbiamo visto aveva inizialmente concesso la pubblicazione del libro seppur sotto precise condizioni, si adirò moltissimo allorché credette di riconoscere sé stesso nella figura dell’ingenuo Simplicio sostenitore del sistema tolemaico, che nel dialogo si contrapponeva a Salviati sostenitore del sistema copernicano.
IL PROCESSO E LA CONDANNA
Di fronte al fatto ormai compiuto, nessuno poté più intercedere per Galileo che, nel 1633, fu chiamato a Roma dal Tribunale dell’Inquisizione, per difendersi dalla pesante accusa di eresia.

|
|
C. Banti - Galileo davanti all’Inquisizione
|
|
|
La precedente drammatica fine del filosofo Giordano Bruno, avvenuta 33 anni prima, sicuramente influì sulla sua decisione di salvarsi. Mentre però il primo difendeva le proprie idee filosofiche, che erano in contrasto con la dottrina della Chiesa, e pur di non rinnegarle aveva preferito andare al rogo, Galileo invece, essendo uno scienziato, non si era mai occupato di questioni filosofiche o dottrinali, lui difendeva semplicemente la realtà, l’evidenza delle cose, che aveva osservato con il suo cannocchiale. Probabilmente si persuase che morire per quella realtà, che qualcuno si ostinava a negare, non ne valeva la pena, perché era certo che la realtà evidente prima o poi sarebbe prevalsa.
Ormai anziano e provato dagli anni che avanzavano, il 22 giugno 1633 Galileo arrivò al monastero domenicano di Santa Maria sopra Minerva e, in considerazione della condanna a morte che lo minacciava, si inginocchiò con un abito bianco da penitente davanti agli inquisitori e abiurò la dottrina di Copernico, leggendo una dichiarazione.
La leggenda vuole che alla fine abbia comunque sussurrato “E pur si muove!” (con riferimento al moto di rivoluzione della terra intorno al Sole), anche se gli storici moderni lo ritengono alquanto improbabile. In ogni caso, queste parole esprimerebbero comunque in modo adeguato l’intimo contegno del caparbio professore convinto profondamente che un giorno la verità scientifica sarebbe finalmente trionfata.

|
|
Sustermans - Ritratto di Galileo (Uffizi)
|
|
|
GLI ULTIMI ANNI
L’abiura dunque gli evitò il peggio e la Chiesa si accontentò di metterlo agli arresti domiciliari nella sua villa di Arcetri, Firenze, per il resto della sua vita.
Ad Arcetri ricevette la visita di diversi illustri visitatori, tra cui i più famosi furono Ferdinando II de' Medici ed il pittore Giusto Sustermans, che dipinse il ritratto più celebre dello scienziato, conservato oggi alla Galleria degli Uffizi di Firenze.
Nonostante il controllo dell’Inquisizione e la progressiva cecità dettata dall’età avanzata, il grande scienziato continuò le sue ricerche, anche grazie all’aiuto della figlia suor Maria Celeste - ubicata in un attiguo convento - che l’aiutava a trascrivere i suoi risultati.
Nel 1638 pubblicò il suo ultimo lavoro “Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze”, grazie al quale ancora oggi è considerato unanimemente il padre della scienza moderna. L’opera era organizzata anch’essa come un dialogo che si svolgeva in quattro giornate fra i tre medesimi protagonisti del precedente Dialogo (Sagredo, Salviati e Simplicio). In quest’ultimo grande lavoro, riassunse mirabilmente le sue ricerche di meccanica condotte per tutta la vita e le leggi che regolano il moto dei corpi.
Il giorno 8 gennaio del 1642 Galileo morì ad Arcetri, Firenze.

|
Monumento funebre di Galileo
Basilica S. Croce - Firenze
|
|
|
Le sue spoglie furono deposte in un primo momento in una tomba nella Basilica di Santa Croce a Firenze e solo nel 1737 Galileo Galilei fu onorato con un grande monumento funebre, che sarebbe stato poi celebrato da Ugo Foscolo ne “I Sepolcri”: «Vide sotto l'etereo padiglion rotarsi più mondi, e il Sole irradïarli immoto, onde all'Anglo che tanta ala vi stese sgombrò primo le vie del firmamento». Il grande poeta peraltro considerava Santa Croce la chiesa delle glorie italiane, essendo stati sepolti altri illustri italiani come Michelangelo, Machiavelli, Alfieri, ecc.

LA FAMA IMPERITURA
Solo in Età Moderna sono stati ufficialmente riconosciuti gli errori della Chiesa nei confronti di Galileo. Il 31 ottobre 1992, ben 359 anni dopo l'abiura, un altro papa, Giovanni Paolo II (di nazionalità polacca come Copernico), ha finalmente riabilitato Galileo davanti alla sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze.
Se l’Inquisizione voleva in qualche modo limitare la memoria di un uomo peraltro religioso e scopritore di molte leggi della natura, non ci è proprio riuscita. Ancora oggi sono moltissime le testimonianze, in ogni campo, della sua fama imperitura.
Al grande scienziato sono state dedicate innumerevoli opere quali strade, piazze, musei, persino una grande infrastruttura moderna come l’Aeroporto internazionale di Pisa, sua città natale.
Sulla vecchia banconota italiana di duemila lire, prima dell’entrata in vigore dell’Euro, c’era impresso il suo celebre ritratto.
Portano il suo nome le Officine Galilei a Campi Bisenzio, che producono strumenti scientifici.
Il drammaturgo tedesco Bertolt Brecht scrisse ben tre versioni dell’opera teatrale denominata “Vita di Galileo” per rappresentare il conflitto tra scienza e potere in tre diverse epoche (fine anni 30, durante la 2a guerra mondiale, periodo guerra fredda).
Non potevano naturalmente mancare gli “omaggi astronomici”.
Una regione di Ganimede, uno dei satelliti di Giove da lui scoperti, è chiamata la Galilea regio.
Nella fascia degli asteroidi, uno di essi catalogato con il n. 796, si chiama Galilea.
Nel 1971, durante la missione Apollo 15 che raggiunse la luna, l’astronauta David Scott della NASA decise di dimostrare, in assenza di resistenza all’aria, l’esperimento di Galileo sull’accelerazione gravitazionale (o dei gravi). In sostanza Galileo affermava che nel vuoto due corpi cadono a terra con la stessa accelerazione, indipendentemente dal proprio peso. Lasciando cadere contemporaneamente un martello ed una piuma, che raggiunsero il suolo lunare all’unisono, l’esperimento riuscì perfettamente!
La sonda spaziale lanciata dalla NASA nel 1989, allo scopo di studiare da vicino il pianeta Giove e i suoi satelliti, è stata chiamata Galileo.
 Il suo nome ha ispirato persino alcuni brani della musica moderna.
Il suo nome ha ispirato persino alcuni brani della musica moderna.
Il celebre gruppo rock dei Queen (clicca link) cita più volte Galileo nel testo del loro pezzo capolavoro “Bohemian Rhapsody”.
L’artista italiano Caparezza ha dedicato una sua canzone al celebre dito medio di Galileo, prelevato in occasione della traslazione del suo corpo nel 1737 nella basilica di Santa Croce e oggi custodito al Museo Galileo di Firenze. In questo museo sono esposte alcune collezioni storiche di strumenti scientifici tra le più importanti al mondo e naturalmente sono presenti gran parte di suoi manufatti che ricordano l’opera di questo straordinario scienziato.
Antonio Pezzullo
|
|
(da sempre ammiratore del grande maestro)
|
Fonti:
I miei primi libri di Storia;
La splendida trasmissione TV “Una giornata particolare” dedicata a Galileo Galilei;
Foto personali o che girano liberamente su Internet.
|